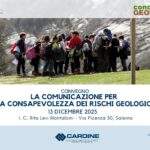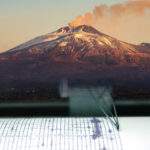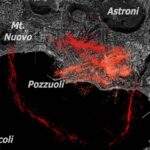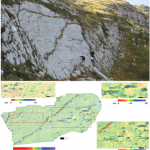Dopo trent’anni di silenzio, l’esplorazione mineraria in Italia torna protagonista. Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha approvato il Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (PNEM). L’iniziativa coinvolge 14 progetti di ricerca distribuiti su 11 regioni, dalla Lombardia alla Sardegna, passando per Toscana, Lazio e Calabria. L’obiettivo? Mappare le risorse minerarie nazionali. Ridurre la dipendenza dall’estero per le materie prime critiche. Quelle indispensabili alla transizione energetica e digitale.
Non si tratta di riaprire le vecchie miniere abbandonate. Si tratta di capire cosa c’è davvero sotto i nostri piedi. Con tecnologie moderne e criteri di sostenibilità che nulla hanno a che vedere con l’industria estrattiva del secolo scorso.
Un investimento strategico per l’autonomia europea
Il PNEM, affidato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) al Servizio Geologico d’Italia di ISPRA, mobilita 15 unità operative. Oltre 400 specialisti sono coinvolti. L’investimento iniziale è di 3,5 milioni di euro dedicati alla prima fase di indagine.
L’iniziativa si inserisce nel quadro del Regolamento europeo sulle Materie Prime Critiche (CRMA), entrato in vigore nel maggio 2024. Il regolamento impone agli Stati membri di elaborare programmi nazionali di esplorazione. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da fornitori esteri, spesso concentrati in aree geopoliticamente instabili.
Attualmente l’Italia estrae solo 2 delle 34 materie prime critiche individuate dall’Unione Europea: feldspato e fluorite. Eppure il territorio nazionale presenta depositi potenziali di litio, rame, tungsteno, cobalto, titanio, terre rare, grafite, antimonio, magnesio, barite e metalli del gruppo del platino. Materiali che oggi importiamo quasi interamente. Ma che potrebbero essere presenti in quantità economicamente sfruttabili nel nostro sottosuolo.
Cosa si cercherà e dove: le aree dell’esplorazione mineraria in Italia
Le aree di indagine sono state selezionate da un gruppo di lavoro coordinato da ISPRA. Il gruppo è composto da alcuni dei massimi esperti italiani di giacimenti minerari. I criteri? Promettenti dal punto di vista geologico. Già oggetto di studi pregressi. Con possibilità di utilizzo di tecnologie innovative.
Nel Nord-Est, Lombardia e Trentino-Alto Adige saranno al centro delle ricerche per fluorite, barite e terre rare nelle Alpi Meridionali. A Nord-Ovest, l’attenzione si concentrerà sull’area di Finero, in Piemonte, per i metalli del gruppo del platino. Nelle ofioliti liguri verranno esplorati giacimenti di rame e manganese. Sempre in Piemonte e Liguria si cercherà di approfondire la conoscenza dei depositi di grafite.
Nel Centro Italia, in particolare in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Marche, sarà analizzato il potenziale del litio. Sia in contesti geotermali che sedimentari. In Toscana saranno oggetto di studio anche i depositi di antimonio e magnesio delle Colline Metallifere. Nel Lazio le attività si focalizzeranno sulla fluorite e sulle terre rare.
Nel Sud, la Campania sarà interessata da indagini sul litio, sui feldspati e su altri minerali industriali strategici. In Calabria verranno esaminati i giacimenti di grafite della Sila.
La Sardegna, storicamente la principale regione mineraria italiana, sarà protagonista con ben 5 progetti su 14. Si studieranno fluorite, rame, tungsteno, feldspati, terre rare e molti altri minerali. Anche in ex distretti come Fontana Raminosa e la soglia di Siliqua.
Tecnologie avanzate e nessun impatto ambientale nella prima fase
Durante la prima fase di esplorazione verranno condotte esclusivamente indagini non invasive. Analisi di immagini telerilevate, rilievi geologici, geochimici e geofisici. Anche mediante sensori aviotrasportati. Saranno inoltre sperimentate tecnologie avanzate come la radiografia muonica, basata sull’utilizzo di particelle cosmiche. E l’impiego di software di intelligenza artificiale per l’elaborazione e l’integrazione dei dati acquisiti.
Eventuali sondaggi esplorativi diretti saranno previsti, ove necessari, solo nelle fasi successive (fase 2 e fase 3). E comunque subordinati alle opportune valutazioni ambientali.
Tutti i dati raccolti confluiranno nel Database Minerario Nazionale GeMMA, sviluppato nell’ambito del progetto GeoSciencesIR del PNRR. L’obiettivo è rendere disponibili le informazioni in modo strutturato, trasparente e consultabile. Per il mondo scientifico, le istituzioni e i potenziali investitori.
Rifiuti estrattivi: un’eredità da bonificare e valorizzare
Parallelamente al PNEM, il progetto PNRR URBES (Urban mining and Extractive waste information System), finanziato con 10 milioni di euro, si occuperà di mappare e caratterizzare i depositi di rifiuti estrattivi abbandonati. Quelli lasciati dalle attività minerarie del passato.
Dei 3.016 siti che sono stati in produzione negli ultimi 150 anni, solo 94 hanno una concessione ancora in vigore. E 76 risultano in produzione. Ben 562 siti minerari dismessi o abbandonati presentano un grado di rischio ecologico-sanitario da medio ad alto.
La Sardegna rappresenta il caso più emblematico. L’area mineraria della Valle del Rio San Giorgio, che comprende il distretto di Montevecchio, ospita 195 discariche minerarie per un volume stimato di 2,8 milioni di metri cubi. E 20 bacini di flottazione che raggiungono complessivamente 13 milioni di metri cubi di rifiuti estrattivi.
Ma questi depositi non sono solo un problema ambientale: possono diventare una risorsa. Molti contengono ancora concentrazioni significative di metalli e terre rare. Con le tecnologie moderne, potrebbero essere recuperati. È il concetto di urban mining, l’estrazione di materie prime seconde da rifiuti industriali.
Un ecosistema minerario da ricostruire
Il PNEM non è solo una questione di geologia. È anche un’occasione per rilanciare un intero ecosistema minerario nazionale. Dopo trent’anni di inattività nel settore dei minerali metalliferi, ha progressivamente ridotto le proprie capacità formative e attrattive.
Il programma prevede infatti un piano di formazione dedicato e un piano di comunicazione per coinvolgere enti locali e comunità. L’obiettivo è ricostruire competenze tecniche e scientifiche nella pubblica amministrazione. Rivitalizzare gli insegnamenti accademici e le scuole minerarie. Sviluppare la ricerca e coinvolgere PMI nazionali e liberi professionisti in ambito geologico, geofisico e geochimico.
“Le materie prime critiche sono fondamentali per il futuro industriale dell’Europa e per la sicurezza degli approvvigionamenti”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “Con il Programma Nazionale di Esplorazione, l’Italia si dota di uno strumento moderno e trasparente per conoscere e valorizzare il proprio potenziale minerario, nel pieno rispetto dell’ambiente”.
Perché l’Italia ha smesso di estrarre minerali?
È luogo comune pensare che l’Italia non disponga di depositi minerari coltivabili. Che le risorse sarebbero scarse o ormai esaurite. In realtà le motivazioni che hanno portato alla progressiva chiusura del settore dell’estrazione dei minerali metalliferi sono più di carattere politico-economico che giacimentologico.
Le vecchie miniere erano obsolete e inquinanti. In un contesto internazionale di grandi disponibilità a basso costo era più conveniente ricorrere ai mercati esteri. Oggi la situazione è drasticamente cambiata. La disponibilità di materie prime di origine mineraria ha assunto un’importanza vitale per l’industria nazionale e continentale. E sono ormai consolidati criteri di gestione sostenibile dell’attività estrattiva.
Una valutazione con moderne tecniche di indagine delle disponibilità delle risorse minerarie nazionali è diventata un imperativo. Indotto da un contesto geopolitico in cui il conflitto economico per l’approvvigionamento delle materie prime si prefigura sempre più esasperato.
Una sfida di autonomia strategica
Il Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria rappresenta un primo passo verso la ricostruzione di una strategia mineraria moderna e sostenibile. Non si tratta di tornare al passato. Ma di guardare al futuro con strumenti nuovi, trasparenza e rispetto per l’ambiente e le comunità locali.
L’Italia non potrà mai raggiungere i livelli produttivi delle grandi economie minerarie come Canada, Australia o Cina. Ma può fornire un contributo significativo alla mitigazione della dipendenza dai mercati esteri, per diversi materiali critici.
In un’economia di transizione, dove la domanda di materie prime critiche è destinata a crescere anche di 10 volte, nessuna strategia basata su un’unica opzione di approvvigionamento può funzionare. Serve un approccio integrato: estrazione sostenibile, economia circolare, ricerca di materiali sostitutivi e collaborazioni internazionali.
Il sottosuolo italiano potrebbe nascondere risorse preziose. Ora è il momento di scoprirlo.