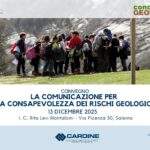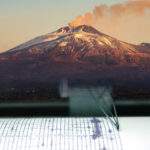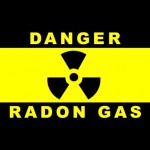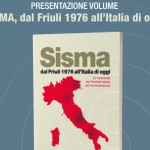Perché alcune stalagmiti crescono appuntite come candele mentre altre si allargano come funghi? La risposta arriva da un modello matematico sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, che per la prima volta spiega come la forma delle stalagmiti dipenda da fattori fisici e chimici precisi.
Un modello matematico per comprendere la forma delle stalagmiti
Il team guidato dal matematico Martin Short ha sviluppato un modello che collega la forma delle stalagmiti alla velocità di flusso dell’acqua, alla concentrazione di carbonato di calcio e al tasso di degassamento della CO₂. Pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, lo studio dimostra che la geometria di queste formazioni non è casuale ma segue leggi matematiche precise.
Quando l’acqua ricca di carbonato di calcio gocciola dal soffitto di una grotta, deposita minerali che si accumulano nel tempo. La velocità con cui l’acqua scorre sulla superficie della stalagmite determina se la crescita sarà verticale e appuntita oppure orizzontale e tozza. Se il flusso è lento, i minerali si depositano principalmente sulla sommità, creando forme slanciate. Se invece l’acqua scorre rapidamente lungo i fianchi, la crescita avviene anche lateralmente, producendo profili più larghi e arrotondati.
Il modello matematico tiene conto di tre variabili fondamentali: la velocità del flusso d’acqua, la concentrazione di carbonato di calcio disciolto e il tasso di rilascio di anidride carbonica. Quest’ultimo fattore è cruciale perché quando la CO₂ si libera dall’acqua, il carbonato di calcio precipita e si solidifica. La forma delle stalagmiti diventa così un archivio geologico leggibile, dove ogni curva e ogni sporgenza racconta una storia di condizioni ambientali passate.
Dalle grotte ai laboratori: verificare la forma delle stalagmiti
I ricercatori hanno testato il modello in laboratorio, facendo crescere stalagmiti artificiali in condizioni controllate. Gli esperimenti hanno confermato le previsioni matematiche: modificando la velocità di flusso dell’acqua e la concentrazione di carbonato, è possibile ottenere forme diverse, dalle punte acuminate ai profili arrotondati.
Questa scoperta apre nuove prospettive per la paleoclimatologia. La forma delle stalagmiti conserva infatti informazioni sul clima del passato: analizzando la geometria e la composizione chimica degli strati, i geologi possono ricostruire temperature, precipitazioni e variazioni ambientali di migliaia di anni fa. Le grotte carsiche, come quelle presenti nell’Oasi di Morigerati rappresentano veri e propri archivi naturali dove queste formazioni si sono sviluppate nel corso dei millenni.
Applicazioni per il futuro della ricerca paleoclimatica
Il modello matematico potrebbe migliorare significativamente l’interpretazione dei dati paleoclimatici estratti dalle grotte. Comprendere come si forma la forma delle stalagmiti significa affinare le ricostruzioni climatiche e prevedere meglio gli scenari futuri. Le grotte diventano così laboratori naturali dove matematica, geologia e climatologia si incontrano.
La ricerca di Oxford rappresenta un passo avanti importante nella comprensione dei processi geologici. Combinando modelli matematici, esperimenti di laboratorio e osservazioni sul campo, gli scienziati possono ora decifrare con maggiore precisione il linguaggio delle rocce. Ogni stalagmite diventa un testimone silenzioso di ere passate, pronto a rivelare i suoi segreti a chi sa interpretarne la forma.
Fonte: www.eurekalert.org